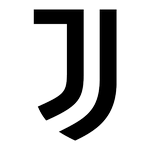«Ci sono un odio e una gelosia nei nostri riguardi che mi spaventano, e che mi fanno riflettere sul divario fra la passione folkloristlca di ieri e la rabbia devastatrice di oggi». Un dirigente della Juventus ha pronunciato queste parole. La domanda è quando. Perché suonerebbero bene in un’intervista a Maurizio Arrivabene di qualche giorno fa, ma in realtà si tratta di una dichiarazione di Giampiero Boniperti del dicembre del 1976. Era il 29 dicembre di quarantasei anni fa quando Tuttosport pubblicava un’interessante inchiesta dal titolo «Com’è difficile fare il tifoso della Juventus», la firmava Carlo, che partiva da una serie di fatti di cronaca. Tifosi e giocatori stessi erano stati vittima di violenza e agguati, ma l’orizzonte del servizio si ampliava, analizzando il sentimento antijuventino che già allora si respirava in Italia.
«E’ ormai facile immaginare quello che accadrà negli stadi dove andiamo a giocare. Se già c’era antipatia nei nostri confronti, si aggiunge anche il sospetto. Nessuno ha più coraggio di portare una bandiera bianconera fuori da Torino», diceva Roberto Bettega nel 1976, mentre l’allora direttore generale Giuliano spiegava che il pullman della Juventus era protetto da una speciale assicurazione, perché alla fine della stagione aveva ricevuto danni per 4-5 milioni di lire, ovvero la stessa cifra tutti gli altri pullman dei club di Serie A sommati insieme. Perché? Boniperti allora parlava di «invidia» e di «gelosia» per i successi. E il nesso fra vittorie e antipatia è, ancora oggi, logico e funzionale all’analisi. Proprio Boniperti, nel 1971, aveva preso una Juventus reduce da un decennio grigiastro e anonimo, durante il quale non aveva suscitato nessun sentimento astioso. I primi scudetti della sua gestione e il ritorno a un ruolo predominante nel panorama italiano ed europeo aveva invece rinvigorito l’opposizione ai colori bianconeri.
In fondo per capire un aspetto importante del nostro Paese c’è un aforisma di Enzo Ferrari che vale dieci tomi di sociologia: «Gli italiani ti perdonano tutto, tranne il successo». E il fondatore di uno dei marchi più famosi del mondo ne sapeva qualcosa: di italiani e, soprattutto, di successo. Sta tutto lì, in quelle otto parole del Drake: vincere va bene, vincere troppo no diventa antipatico. Perché in Germania non esiste un così radicato sentimento anti-Bayern, che domina in modo anche più brutale la scena calcistica nazionale? Al club bavarese vengono, anzi, sempre riconosciuti i meriti e traspare quasi un orgoglio nazionale quando ottiene successi all’estero.
La Juventus raccoglie, viceversa, un diffuso tifo contro che raggruma in modo trasversale l’antagonismo, raccogliendo sostenitori di tante squadre diverse, fino al punto da poter sostenere che in realtà pochi sono veramente neutrali e il Paese calcistico si divide sostanzialmente in due: juventini e anti-juventini. E, come spesso accade in politica (ahimè), non c’è più logica, critica, analisi, ma solo faziosità e divisione in due partiti: o stai da una parte o stai dall’altra, o attacchi o difendi, non puoi ragionare, né distinguere, o stai dentro o fuori.
Sono queste circostanze ad aver fertilizzato il terreno per il mestiere dell’anti-juventino. Perché in un mondo che premia l’audience, ammiccare al 75% dei tifosi italiani può anche essere un affare. E per qualcuno lo è diventato: costruirsi un personaggio che attacca la squadra «più potente d’Italia» significa anche poter diventare il paladino di una consistente parte degli appassionati, quindi raggiungere un’audience monetizzabile e crearsi un’immagine da duro che non “si piega ai poteri forti”, ma che difende una minoranza. Il che è buffo perché in realtà si sta rivolgendo a una maggioranza, così come il fatto che la Juventus venga identificata come la squadra dei ricchi, come se gli storici proprietari del Milan o dell’Inter fossero poveri (si pensi a quando erano Berlusconi e Moratti) o “piccoli imprenditori”. Tutte le grandi squadre sono uguali e hanno uguali interessi e, quindi, atteggiamenti: ma la percezione è diversa. Identici comportamenti hanno avuto trattamenti opposti (anche nell’ambito della giustizia ordinaria). Forse anche perché, più in generale, chi va contro la Juventus appare quasi sempre come un eroe che sfida l’impossibile, mentre non è più difficile rispetto a qualsiasi altro grande club.
Oggi, nel nuovo scenario dei social, sui quali il seguito e l’attenzione si trasformano in soldi, essere anti-juventini è per molti un mestiere. Funziona, genera dibattito o, per usare il termine tecnico: “engagement”; perché c’è il 70% dei tifosi che sono potenzialmente d’accordo con quello che dici e il 30%, ovvero i tifosi bianconeri, che sono morbosamente interessati a quello che dici, anche solo per arrabbiarsi con te. E il dissenso, sui social, genere sempre più attenzione che il consenso. Si arriva, insomma, al paradosso che - per così dire - parte dello “stipendio” degli anti-juventini viene pagato dagli juventini stessi che generano traffico su notizie o post che, a ragione o torto, parlano male della loro squadra. Tutto questo indisturbati. Perché la Juventus non ha l’abitudine di smentire, contraddire, contrattaccare mediaticamente. «Smentire una bufala è come diffonderla due volte», recita il manuale del perfetto ufficio stampa e il concetto conserva ancora oggi un fondo di verità. E, più in generale, discutere con un oppositore sistematico finisce per dargli ancora più importanza. Questa è la filosofia della società, che poi è la filosofia degli Agnelli che l’ha sempre adottata nell’universo Fiat: «Che gli altri parlino, noi facciamo», usava dire il senatore Giovanni, patriarca della famiglia, quasi a segnare il distacco fra le chiacchiere e il lavoro.
Non sempre questa scelta piace ai tifosi, una delle richieste più frequenti è di essere difesi, di dare delle risposte forti, di andare all’attacco, anche attraverso vie legali. Vorrebbero, insomma, che la Juventus combattesse l’antijuventinismo, pronti a correre il rischio che questa battaglia faccia il gioco proprio di chi ne ha fatto un mestiere e il rischio più grosso che corre è quello di non essere considerato.