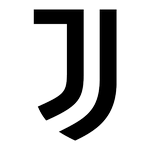Andrea Lorentini aveva tre anni, e suo fratello uno e mezzo, quando suo papà Roberto è morto all’Heysel. Di lui non ha ricordi diretti, ma solo ciò che il nonno, la mamma, i parenti e gli amici gli hanno raccontato. «Il mio babbo era un medico, il giorno prima della tragedia aveva ricevuto la lettera di assunzione in ospedale. Tifava Juve, ma non era un ultras, l’anno prima era andato a Basilea per la finale di Coppa delle Coppe, decise di ripetere l’esperienza anche a Bruxelles con nonno Otello, tifoso viola, e due cugini. Proprio mio nonno, crescendo, ci ha spiegato quello che è successo: papà era riuscito a mettersi in salvo, poi ha visto un bambino, Andrea Casula, in difficoltà, è tornato a prestargli soccorso, gli stava praticando la respirazione bocca a bocca quando entrambi sono stati travolti da una nuova carica. Li hanno trovati insieme».
Andrea, come si sente quando si avvicina il 29 maggio?
«Mio padre è vivo nei nostri ricordi tutto l’anno, in vari momenti della nostra vita, però quando si avvicina questa ricorrenza cresce la malinconia e la tristezza, riapre una ferita che non si rimargina: a volte brucia meno, a volte di più. Se non ci fosse stata questa tragedia la nostra vita con mio padre poteva essere differente, non avremmo vissuto questo dolore».
Come vorrebbe che fosse ricordato suo papà?
«Per il suo gesto di grande altruismo che gli è valso anche una medaglia d’argento al valore civile. E’ stato un esempio, un punto di riferimento, morto aiutando gli altri e io sono orgoglioso di ciò che ha fatto».